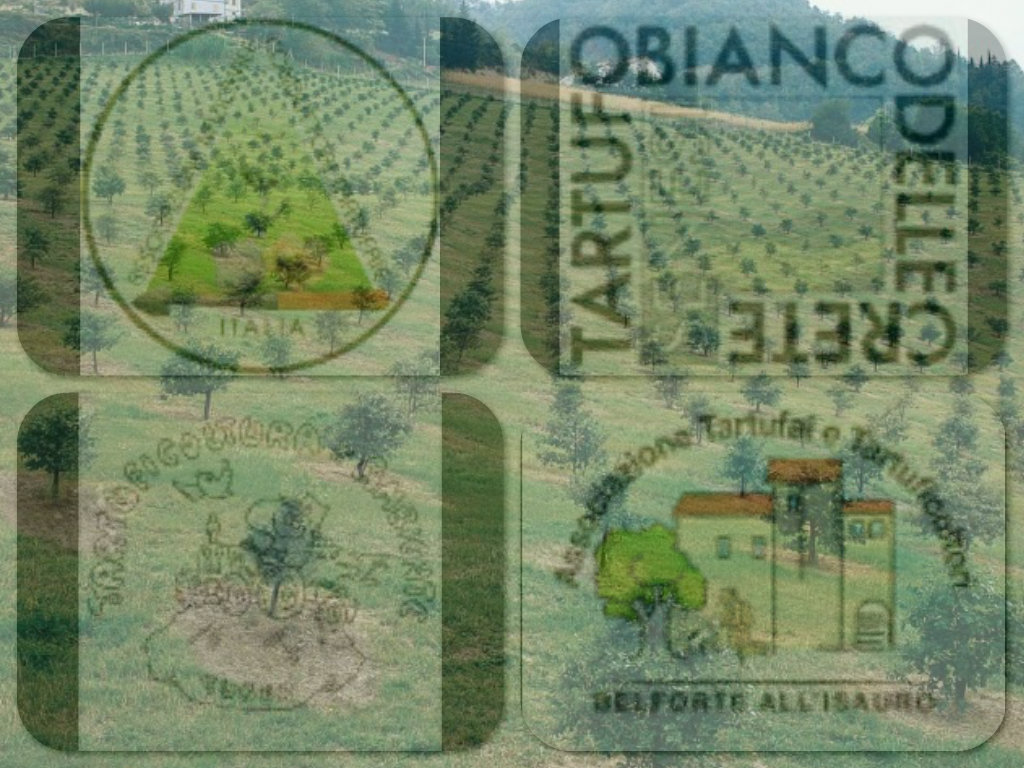L’irrigazione nelle tartufaie coltivate
L’irrigazione nelle tartufaie coltivate
L’irrigazione nelle tartufaie coltivate – Iniziamo subito col dire che le modalità d’irrigazione dipendono dai tipi di terreno, dalle condizioni climatiche, dallo stato della vegetazione e dalle effettive disponibilità idriche; in caso di notevole disponibilità di acqua il metodo più razionale sembra essere quello a micro-aspersione che è il più simile alla pioggia; in caso contrario può essere utilizzato il metodo a goccia che consente sensibili risparmi idrici.
In tartuficoltura la qualità delle acque utilizzate per l’irrigazione riveste molta importanza e la preferenza deve andare alle acque neutre od alcaline di pozzi e sorgenti piuttosto che a quelle di origine pluviale raccolte in appositi invasi. Attualmente in alcune situazioni le acque di pioggia, acide perchè cariche di SO2 e CO2 diventano aggressive nei confronti del calcare che dissolvono e dilavano. Una certa acidità dell’acqua può provocare, a più o meno breve scadenza, una decalcificazione del suolo molto pregiudizievole per il tartufo, per il quale il calcare è un elemento indispensabile.
Inoltre queste acque possono, per dissoluzione di altri elementi creare degli squilibri fisiologici sulle piante simbionti che si ripercuotono sul fungo. Sembra che in Francia (sud-ovest, zona di Bordeaux) l’acidità delle piogge sia una delle cause che hanno abbassato il pH del suolo con una conseguente diminuzione della produzione dei tartufi (Poitou, 1989).
Per questo è molto importante l’analisi e la sorveglianza della qualità delle acque usate per l’irrigazione della tartufaia.
A proposito della quantità d’acqua da apportare va detto che dosi eccessive conducono ad un arresto definitivo della tartufaia dopo una produzione “miracolo” di un anno o due. Per il Tuber melanosporum, secondo il tipo di suolo, l’insieme pluviometria-irrigazione potrà variare da 30 a 60 mm al mese; gli apporti nel periodo secco possono essere frazionati in quantità di 10 mm per irrigazione, che va ripetuta ogni 10 giorni (Poitou, 1989). Perché gli interventi siano più efficaci sarebbe opportuno installare sulle tartufaie un pluviometro mobile la cui forma e dimensione consentano di spostarlo ed utilizzarlo non solo per registrare le precipitazioni naturali e decidere il momento dell’intervento sulla base dei giorni di siccità, ma anche per registrare la quantità d’acqua somministrata con l’irrigazione che deve risultare complementare alle precipitazioni quindi nè scarsa e perciò inutile nè eccessiva e quindi addirittura dannosa.
Nel caso del Tuber magnatum, pur comprendendo che l’irrigazione può risultare determinante per lo sviluppo dei corpi fruttiferi ma non avendo ancora sufficienti indicazioni, si interviene nei periodi di eccessiva aridità somministrando acqua anche fino a 150 mm complessivamente. Questa irrigazione di soccorso, che si rivela necessaria soprattutto in condizioni di siccità prolungata, potrebbe apportare 50-60 mm in luglio, in agosto ed eventualmente in settembre, lasciando tuttavia che si stabilisca fra un intervento e l’altro un periodo di 10-15 giorni di relativa siccità. Durante l’irrigazione è importante non affogare il suolo d’acqua ed evitare ristagni sotterranei che sono dannosi al micelio del tartufo perchè causano malattie al colletto delle piante simbionti (marciumi radicali). L’irrigazione va praticata la sera tardi, la notte o il mattino presto, oppure con il tempo nuvoloso, in maniera da evitare il raffreddamento del suolo provocato da una intensa evaporazione.